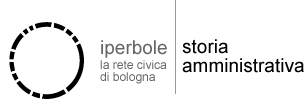Bologna nodo ferroviario strategico negli anni dell'unità nazionale
Alberto Bortolotti, Il nodo ferroviario di Bologna e il collegamento transappenninico negli anni di formazione della rete nazionale
La ferrovia Piacenza-Bologna-Pistoia, in costruzione durante i travagliati anni di formazione dello Stato unitario, consentiva nel 1864 il primo collegamento veloce tra il Nord e il Sud della nostra penisola. Al momento del suo completamento la linea vantava la realizzazione di opere rispondenti ai modelli tecnologici e costruttivi messi a punto durante la prima metà del secolo dalle più note scuole politecniche d’Europa, sotto l’impulso dello sviluppo economico delle grandi regioni industrializzate. Le vicende di questa ferrovia coinvolsero i diversi stati dell’Italia centrale, ma nonostante le fortissime pressioni locali e il miraggio di ingenti guadagni da parte delle società straniere la sua realizzazione procedeva inizialmente a stento. Nella complessa scena politica del tempo, l’Austria aveva elaborato un proprio disegno strategico, in funzione essenzialmente antipiemontese, per costituire un collegamento tra i due mari Adriatico e Tirreno, quindi tra i porti di Trieste e Livorno, sotto il suo intero controllo. Poteva contare sulla propria influenza sui ducati di Parma, Piacenza e Modena, e sul legame di parentela col ducato toscano dei Lorena. Secondo le intenzioni, il collegamento asburgico da costa a costa avrebbe potuto servirsi della linea Ferdinandea tra Venezia e Milano, per innestarsi sul nuovo tronco tra Piacenza e Bologna attraverso gli stati emiliani, che sarebbe stato terminato nel 1859, per poi attraversare gli Appennini presso Porretta, al confine col Granducato toscano, seguendo il tragitto Trieste-Venezia-Verona-Mantova-Reggio-Bologna-Pistoia. Poiché il tratto da Castelfranco a Porretta transitava in territorio pontificio, sarebbe stato necessario l’appoggio di papa Gregorio XVI, che però era noto per la sua aperta ostilità a simili innovazioni. Di qui le forti pressioni dei cittadini bolognesi che, temendo la realizzazione di un valico ferroviario alternativo per l’Abetone, si riunirono in comitati, predisponendo studi di fattibilità e progetti, anche se la situazione sarebbe cambiata radicalmente solo con l’ascesa di papa Pio IX.
È curioso che le prime istanze fossero mosse in primo luogo per incentivare l’esportazione agricola, sottovalutando le ricadute della ferrovia sull’economia regionale nel settore industriale, di fatto inesistente nelle aree attraversate, a differenza di quanto avveniva nel contempo in Europa. Tra i principali promotori fu la Società Agraria Bolognese, col sostegno dei nobili proprietari terrieri, presieduta dall’ingegner Pietro Pancaldi. Tra le prime proposte, quella del Pancaldi (1839) prevedeva una linea dal Po, nei pressi di Ferrara, al confine toscano di Porretta.
Una prima convenzione fu finalmente stipulata il primo di maggio 1851 tra l’Impero Asburgico, i due Ducati emiliani, il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio, atto che promuoveva i collegamenti infrastrutturali tra i diversi stati.
Il tracciato doveva, da Piacenza, affiancare la via Emilia in direzione di Bologna, attraversando poi l’Appennino presso Porretta, nel punto che fin dall’inizio Vienna aveva ritenuto il più adatto. Invano i Pratesi avrebbero cercato di dirottare il transito della linea al valico di Montepiano, che in effetti fu ritenuto più idoneo molti anni più tardi per la costruzione di una seconda transappenninica, la direttissima Bologna-Firenze (completata negli anni Venti del XIX secolo).
A seguito della convenzione del 1851, i primi risultati furono del tutto insoddisfacenti, per gli oneri esorbitanti che la società concessionaria non era in grado di sostenere. Il governo austriaco, che conduceva di fatto la regia di tutta l’operazione, decise allora di ricorrere agli ingenti capitali dei Rothschild, stipulando una nuova convenzione nel 1856. Fu allora che la nuova società concessionaria, appositamente costituita (Società delle Strade ferrate del Lombardo Veneto e dell’Italia Centrale) ingaggiò l’ingegnere lorenese Jean Louis Protche a dirigere i lavori, chiamandolo in ottobre a Bologna.
Il successo dell’impresa, portata a termine in tempi relativamente brevi, si può imputare in gran parte alla capacità di gestione del complesso apparato burocratico amministrativo e alla prontezza di soluzione dei problemi di cantiere, in condizioni non certo favorite dal clima politico di estrema incertezza. Validi progettisti come i Cini, il Lapini o il Pohlmeyer, nei precedenti tentativi, avevano in ogni caso già predisposto progetti validi, poi assunti dal Protche come punto di partenza per le proprie successive riflessioni, ma non erano stati supportati da una congeniale attività di gestione delle risorse.
L’abilità di coordinamento dell’amministrazione della nuova società si era fin da subito manifestata agli occhi della popolazione e della classe dirigente locale, per una serie di circostanze che avevano portato alla sinergia di importanti personalità del mondo politecnico, politico e finanziario. In primo piano la perspicacia professionale e la determinazione del Protche e dei suoi collaboratori, tra cui l’ingegnere triestino Ehrenfreund; alle spalle la sicurezza e la forza economica di uno dei più potenti gruppi finanziari d’Europa, i Rothschild; tra le parti la straordinaria esperienza gestionale e politica di Paulin Talabot, tra i principali promotori della linea e da tempo alla direzione della più importante linea ferroviaria francese, la Parigi-Lione-Marsiglia; infine la sollecitazione dei governi prima austriaco, poi piemontese, nella corsa all’armamento ferroviario per la supremazia nazionale.
La trasposizione alle ferrovie italiane del modello organizzativo politecnico francese, fondato su una divisione rigidamente gerarchica del lavoro sulla base delle competenze acquisite, giocò anch’essa ruolo di primaria importanza, riducendo notevolmente i tempi di realizzazione sulla base di programmatici e coordinati rapporti di cooperazione. La società si organizzò in modo da poter controllare costantemente le fasi di esecuzione tramite una direzione generale a Verona, affiancata da due direzioni dei lavori: la prima, ancora a Verona, si interessava delle strade ferrate lombarde, la seconda, a Bologna, seguiva quelle dell’Italia centrale.
Dalla direzione bolognese dipendevano gli ingegneri di divisione, generalmente francesi, dislocati a Reggio, a Modena, a Bologna e a Porretta; da essi poi dipendevano gli ingegneri di sezione, distribuiti uno ogni dieci chilometri di tracciato; a questi ultimi erano subordinati gli assistenti e i disegnatori, incaricati dei rilievi e delle misurazioni in opera. Un piccolo esercito di tecnici si muoveva attraverso i cantieri delle ferrovie, utilizzando uno stesso linguaggio di rappresentazione grafica e attingendo al patrimonio di conoscenze tecnologiche acquisito attraverso l’Europa.
In quegli anni Bologna si avviava a divenire un nodo ferroviario di grande importanza. Oltre alla prima tratta Bologna-Piacenza, terminata nel 1859, fu completata nel 1861 la Bologna Ancona, l’anno successivo la Bologna-Pontelagoscuro, l’unica a non essere progettata precedentemente all’unificazione. Sempre nel 1861, precisamente il 14 novembre, fu inaugurata la Milano-Piacenza, mentre procedevano rapidamente i lavori di prolungamento verso la Puglia.
Nel 1864 il completamento del ramo appenninico Bologna-Porretta-Pistoia, che presentava le più rilevanti difficoltà tecniche di realizzazione, suscitava un grande entusiasmo nelle piccole comunità come ai vertici dello Stato unitario. Tra le prodezze costruttive messe a punto lungo tutto il tragitto, si contavano inizialmente 46 gallerie e 35 ponti e viadotti. Tra le innumerevoli soluzioni d’avanguardia si annoverava la prima galleria elicoidale d’Europa, costruita presso Piteccio. L’espediente, divenuto subito un modello per il superamento delle forti pendenze lungo i tracciati ferroviari montani, sarebbe stato ripreso successivamente per la realizzazione del traforo del Frejus.
La particolare conformazione orografica delle valli appenniniche attraversate aveva suscitato non pochi problemi. Mentre il tratto di ferrovia da Bologna a Porretta raggiungeva una pendenza massima del 12 per mille, sul versante toscano, raggiunta l’altitudine di 616 metri a Pracchia e superata la galleria dall’Appennino, era stato necessario superare un dislivello di 553 metri in appena 14 km in linea d’aria. La soluzione, già ipotizzata da alcuni tecnici delle precedenti società concessionarie, prevedeva di snodare i binari secondo due grandi anse che conducevano alternativamente nella valle dell’Ombrone e del Brana. Tale ipotesi aveva prospettato fin da subito la necessità di realizzare un numero consistente di viadotti, che avrebbero raggiunto l’altezza di 40 o 50 metri dal fondovalle. L’importante innovazione introdotta dal Protche, era stata di far correre i binari con le curvature e le pendenze stabilite anche entro terra. La galleria di Piteccio venne così concepita ad “S”, a doppia curvatura discendente in direzione di Pistoia, con raggi di circa 300 metri, per una lunghezza di 1753 metri. Ciò consentiva il mantenimento di una pendenza del 22 per mille in galleria, ma ne beneficiava tutto il tracciato toscano, la cui pendenza non superava il 26 per mille.
Il progetto dell’intera linea è oggi custodito presso il fondo Protche, donato nel 1890 alla Biblioteca dell’Archiginnasio da Sofia Protche, quattro anni dopo la morte del padre. Il fondo è da considerare tra le più importanti riserve documentali sui progetti delle ferrovie ottocentesche. Sulla linea Centrale italiana si trovano un gran numero di disegni tecnici: planimetrie, profili lugitudinali e trasversali di tutto il tracciato suddiviso in tronchi, con indicazione esatta dell’altimetria e dei manufatti ferroviari, giornali di cantiere, una cospicua corrispondenza con i soggetti pubblici e privati, copie di atti ufficiali ecc. Oltre all’attività svolta in Italia dal 1856, il fondo documenta anche con una sostanziosa raccolta le attività svolte in Francia da Protche nei primi anni della carriera, delle quali è fatta menzione negli Archives Nationales parigini e nei registri dell’École des Ponts et Chaussées.
Dalla lettura dei disegni redatti dalle squadre di ingegneri alle dipendenze del Protche, emerge chiaramente che il progetto delle ferrovie comprendeva la necessità di trasmissione di un gran numero di conoscenze e di soluzioni ai cantieri, secondo schemi convenzionali di rappresentazione ben precisi, che sarebbero stati adottati anche nei progetti moderni. Ai disegni dei manufatti si accompagnano infatti i progetti delle macchine, oltre ai procedimenti e ai programmi per la loro realizzazione. Compaiono dettagli esecutivi di centine per la realizzazione degli archi in muratura, impalcature e strutture provvisorie, palizzate di contenimento degli scavi, piattaforme per il carico e lo scarico dei materiali, schemi di leve, sistemi di condotte idrauliche, argani movimentati da animali. A ciascun schema grafico è assegnato un nome e un codice di riferimento, che rimanda alle dettagliate note esplicative, ma anche alla lettura dei capitolati, con indicazione delle quantità e dei costi secondo unità di misura uniformate. Viene in altre parole a delinearsi compiutamente il complesso apparato tecnico amministrativo e documentale necessario al sistematico avanzamento della fabbrica delle ferrovie.
Riferimenti bibliografici
J. Benetti, Notizie intorno alla ferrovia appenninica da Bologna a Pistoia, in: L’Appennino bolognese Descrizione e itinerari, C.A.I., Bologna, 1881, p. 409
E. Ehrenfreund, L’opera dell’Ing. G. L. Protche nelle ferrovie italiane, in «Il Comune di Bologna», XXI, n°6, giugno 1934, pp. 65-68
A. Giuntini, Jean Louis Protche, ingegnere ferroviario lorenese in Italia, in «Il Carrobbio», a. XIII, Ed. Luigi Parma, Bologna, 1987, pp. 240 245
Id., I giganti della montagna. Storia della ferrovia Direttissima Bologna-Firenze (1845-1934), Firenze, 1984
G. Losi, Viaggio in strada ferrata da Bologna a Firenze per Pistoia, Reggio Calabria, 1880
C. Masini, Necrologia dell’Ingegnere Gioan-Luigi Protche presidente della R. Accademia di Belle Arti di Bologna, Regia Tip., Bologna, 1886
V. Montanari, Il Fondo Protche, una grandiosa serie di documenti che illustrano, in 478 volumi, 93 atlanti e 44 cartoni, la storia della viabilità ferroviaria italiana, in «Bologna incontri», XVII, 11, novembre 1986, pp. 29-30
M. Panconesi, Le ferrovie di Pio IX, Calosci, Cortona, 2005
Id., Porrettana trekking. Ricognizione storica lungo le antiche vie di servizio delle strade ferrate Pracchia-Pistoia, Edi Libra, Firenze, 1992
Id., Porrettana perduta. Alla riscoperta delle testimonianze di archeologia ferroviaria lungo la leggendaria Strada ferrata degli Appennini, La Vaporiera, Cento, 1999
Panorama della Strada Ferrata delli Appennini, Giulio Wenk Editore, Tip. Fava e Garagnani, Bologna, 1865, edizione in fac-simile a cura di R. Zagnoni e G. P. Borghi, Gruppo di Studi Alta Valle del Reno, Porretta Terme, 2008
J. L. Protche, Osservazioni intorno ai provvedimenti ferroviari interessanti Bologna, Regia Tip., Bologna, 1877
Recueil de dessins d’exécution concernant, sauf indication spéciale, la ligne de Bologne à Pistoie, Dressé sur la demande des ingénieurs ayant pris part a l’exécution des travaux pour être mis à la disposition des mêmes ingénieurs, sous la direction de l’ingénieur en chef des travaux J. L. Protche, Compagnie des chemins de fer de la Haute Italie, Regia Tipografia, Bologne, 1864
A. Sorbelli, I manoscritti Protche, in L’Archiginnasio, Bullettino della Biblioteca Comunale di Bologna, diretto da Albano Sorbelli, anno IV, 5, Cooperativa Tipografica Azzoguidi, Bologna, 1909
R. Zagnoni (a cura), La ferrovia transappennina, il collegamento nord-sud attraverso la montagna bolognese e pistoiese (1842-1934), Gruppo Studi Alta Valle del Reno, Tip. Ferri, Bologna, 1985
R. Zagnoni e A. Ottanelli (a cura), Vedute fotografiche della costruzione della ferrovia Porrettana (1859-1864), Gruppo di studi alta valle del Reno, Porretta Terme, 2009.