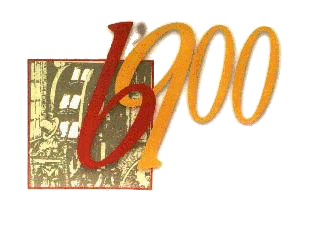
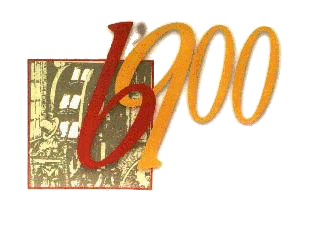 |
Agli interconnessi (5) |
Chiamarsi "Bollettino '900" alle soglie del Duemila può sembrare stonato e retrogrado, per chi voglia occuparsi di contemporaneità: una beffa che fa il tempo - a noi che siamo in bilico. Eppure tale condizione di vecchio presente, di contemporaneità attempata, oltre che determinata dalla contingenza cronologica, è sintomatica di una situazione epocale. Che si abbia fretta di lasciarsi indietro il secolo per un'era nuova o che ci si aggrappi ad esso per scongiurare questo passaggio, in ogni caso si è certi di essere già in un tempo nuovo che pure affonda profondamente nel vecchio. Vero è che "Novecento" comincia a essere dubbia categoria storiografica più che segno del tempo presente: fino a un decennio fa e anche più recentemente del tutto ignorato nella maggior parte delle scuole e delle università, ora già rievocato con accento nostalgico, impacchettato nei pamphlet, congedato, sepolto o celebrato con numerosi e affrettati bilanci. Eppure anche a volerlo considerare unitariamente il "secolo breve", secondo la denominazione di Berend e Hobsbawm, è tutto rivolto all'esterno, è secolo di transiti, di sintesi inconcluse, di scontri e di posizioni estreme. Non sembra perciò unificabile, ma nemmeno scindibile in modo netto: travalica le nostre scansioni cronologiche di natura percettivo-numerica. Fagocita, classifica e conserva più di ogni altra era della storia umana, raccoglie, organizza e distribuisce i retaggi di un tempo lungo non più visto deterministicamente eppure forse mai prima d'allora percepito con tale ampiezza e articolazione. Forse proprio in questa faticosa invenzione della coscienza plurale, in questa consapevolezza della inattingibile diversificazione della realtà effettuale, e non in altro, può essere individuato un carattere comune di questi ultimi cento anni.
Eppure tanto di ciò che ci riguarda, di ciò che sembra mutare le nostre categorie percettive e esistenziali sembra trovare riscontro in quegli anni (decennio più, decennio meno) che ci precedono. Non tanto perché in qualche punto del secolo abbia avuto origine qualcosa che ora cresce e si sviluppa, ma perché noi ora abbiamo elementi per comprendere in modo diverso fenomeni che prima si confondevano nello sfondo affollato. Altri modelli e caratteri che a volte vengono indicati come simboli della contemporaneità, espunti dal catalogo degli oggetti e delle forme novecentesche, in realtà muovono tutti verso la molteplicità, contengono l'ossessione del divenire e il motore per la propria distruzione: sembrano vettori più che valori. Il secolo vasto e denso, più che breve o lungo, che si caratterizzi via via come evo della relatività, del principio di indeterminazione, della sincronia, della scolarità di massa e delle scienze umane, si sparpaglia in diverse temporalità e geografie. In tal modo diviene per noi una prospettiva di lavoro. La "modernità" ha avuto sempre un gusto spiccato per le scansioni cronologiche, per il terminus ad quem e per il terminus a quo, ordinando il reale in prospettive olistiche e progressive. Il postmodernismo ha ereditato, paradossalmente, questa passione per le discontinuità in funzione dell'autoriconoscimento, e ha canonizzato la "modernità", tentando di fissarne gli indici e le dominanti.
A questo modo di vedere forse ora si aggiunge una diversa sensibilità, che percepisce cesure parziali, procede su livelli differenziati, individua tagli longitudinali. Convivono e confliggono diverse tradizioni, diversi canoni, diversi paradigmi con le loro antichissime e intrecciate radici. Fissare paletti univoci non sembra più un compito rilevante della storiografia: all'attenzione per la continuità, poi per la discontinuità cara a Foucault o Heidegger, si aggiunge ora l'attenzione per le convivenze. Le durate sono molteplici e si sovrappongono, si intersecano. La differenza, più che un emblema, è un metodo necessario. Questo non significa necessariamente relativismo o neostoricismo, che sono poi il piatto dilagare del presente e la reazione ad esso, ma forse un avvicinamento obbligatorio della critica alla "contemporaneità" che è tutt'altra cosa dal "presente". È forse il caso di praticare una storiografia retroattiva, che va a cercarsi le strade, non per giustificare lo stato di fatto, ma per affrontarne i problemi (in questo caso estetici, formali, artistici, retorici). La critica, da parte sua, dovrebbe sempre essere "militante", nella misura in cui prende la propria responsabilità nel chiedersi che cosa si può fare con ciò di cui essa si occupa, e nel tentare di individuare il da farsi, preferendo un pensiero forte parziale a un pensiero debole globale.
D'altro canto tale visione differenziale del contemporaneo, proprio per le ragioni che si sono dette, non significa nemmeno "fine della storia", ma solo forse davvero la fine di una particolare filosofia della storia, l'abbandono di un pensiero che potrebbe definirsi "parabolico" che sempre è soppravvissuto nascostamente anche nei pensatori moderni meno metanarrativi, empirici o strutturali che fossero. Ogni filosofia della storia di tipo parabolico è in fondo un pensiero di morte, una proiezione della vicenda biologica individuale nella sfera cosmologica che mantiene sempre salda l'idea di una prospettiva unitaria entro cui questa parabola si produce. Quello che chiamiamo sentimento ipermoderno può essere inteso come tentativo di beffare la modernità in alcuni suoi capisaldi, quale per esempio questo pensiero della fine, per intraprendere invece pragmaticamente un pensiero degli inizi. Potenziando, in storiografia, ciò che può definirsi il tentativo di costruire sempre un'"efficacia potenziale" delle scelte specifiche e della stessa attitudine selettiva della conoscenza storica.
Tutto ciò, in letteratura, può voler dire interrogarsi su quali forme di arte verbale possano oggi prodursi, su quali generi detengano o promettano al tempo stesso un discreto coefficiente comunicativo e una rilevanza estetica. Proprio su questi temi stiamo lavorando, e sulla ricomprensione del concetto stesso di "genere". Una delle tappe in questa direzione è stato il seminario sui "Generi marginali nel Novecento letterario", di cui contiamo di poter pubblicare presto gli Atti.
Se perdura da più di un secolo una contraddittoria sensazione di marginalità e di eccellenza della letteratura, una pratica di esaltazione retorica e di proclamazione della sua fine, sembra che tutto ciò faccia parte di un fenomeno più generale, che influenza anche lo spazio letterario: la trasformazione riguarda presumibilmente, oltre che la politica e l'economia, la struttura stessa della memoria e la sfera simbolica in toto. Ma, di là dalle perturbazioni epocali, qualche spunto per non ritenere che gli unici due destini possibili della letteratura siano l'estinzione o la sopravvivenza museale sembra rilevabile in fenomeni che pure sono stati studiati principalmente nella sfera politica o antropologica, come la "perdita di territorialità" di cui ha parlato Charles Maier, o la "crisi delle retoriche intermedie" di cui ha discusso Marc Augé. Il primo aspetto riguarda strettamente il letterario, oltre che su un piano tematico e disciplinare, sotto l'aspetto della trasmissione delle forme e dei testi. Nel Novecento non sembra più possibile non tanto una geografia dello spazio interno, un atlante cognitivo come nell'ultimo libro di Franco Moretti o nella cronotopica bachtiniana, ma una geografia della diffusione delle forme e della ricezione delle forme. Non conta se tale impresa sia o non sia mai stata veramente tentata, o se sia possibile e utile, secondo un modello positivistico. Conta che la critica moderna, anche in certi suoi estremi strutturalistici, ha sempre tenuto conto, più o meno consapevolmente, della territorialità dell'opera, dei suoi vincoli di vicinanza, fossero essi storici o teorici. Anche l'intertestualismo di ultima generazione ha creato sempre se non altro un territorio "sistemico" di riferimento, sopratutto se l'intertestualità stessa diveniva luogo primario di riconoscimento della letterarietà. Ovvero le sue applicazioni, a diversi livelli, sia che tendessero al recupero della soggettività del lettore, sia che privilegiassero la costrittività del testo, sia che infine tenessero in primo piano codici, cultura o contesti, avevano un quadro chiaro dei canoni, dei generi e dei macrogeneri, creavano uno spazio teorico, un territorio disciplinare. Ora ciò, grazie anche a una microfisica dell'espressività, a una moltiplicazione dei canali, a una ridondanza dei prodotti, diviene, come noto, quanto mai problematico. Ogni territorio non sembra altro che un "contesto occasionale" che spinge per lo meno a riproblematizzare il concetto stesso di contesto. L'unico livello d'indagine che mantiene una sua inalterabile tetragona legittimità è l'idiografico, che si serve di collaudati microscopi filologici. Eppure, proprio quando sembra che l'unica possibilità della critica rimanga, tanto dal punto di vista dell'interprete quanto dell'interpretando, quella dei percorsi individuali, che possono nella migliore delle ipotesi incontrarsi e riconoscersi, viene da pensare che tale perdita di territorialità fisica e teorica possa riportare l'interesse su forme di territorialità virtuale: lo stile, proprio inteso come spazialità, forma di forme, può esserne un esempio, a patto di mutarne completamente la definizione e la portata, ridurne la dipendenza da autore, opera, testo, e ritrovarne le potenzialità estetiche proprio nella capacità di costruire relazioni intertestuali e ipertestuali.
Il pluristilismo, per quanto riguarda in primo luogo il mondo artistico, non sembra più tanto una scelta individuale ma una contrattazione di differenti entità autoriali. Questo secolo, dal fenomeno delle riviste al cinema, dalle spettacolarizzazioni al Web, mostra molti esempi di una tendenza a una intertestualità "produttiva" prima ancora che "ricettiva". E tuttavia la stessa tradizione letteraria, a cominciare dalla Bibbia fino al melodramma, ma in generale per la massima parte del suo sviluppo, è colma di scritture accorpate e stratificate: l'opera individuale, lo stile autoriale, occupa presumibilmente un minuscolo spazio nella coscienza della scrittura così come si è attestata nei "contesti occasionali" che si possono isolare in tutto il suo articolato manifestarsi, dall'invenzione dell'alfabeto fino alla scrittura digitale.
Ma se lo stile diviene una configurazione al tempo stesso storica e mobile che si irradia (anche mantenendo come punto di vista privilegiato l'espressione verbale) in una molteplicità di relazioni transtestuali, per usare il termine di Genette, o situazionali, lo stesso concetto di "genere" rischia di divenire instabile e improduttivo proprio perché non è più luogo di incontro significante tra testi. L'ibridazione tra generi è un dato bruto di partenza, un'interdiscorsività preliminare contro la quale una configurazione stilistica deve aprire, contrattando, la propria via verso una rilevanza anche estetico-formale. Il paradosso potrebbe essere che una scrittura non ha più, tendenzialmente, un genere di appartenenza, ma solo generi di destinazione. La critica stessa entra negli "stili", la ricezione è una prosecuzione della produzione con altri mezzi, una partecipazione non pacifica all'attualizzarsi dell'"opera". Ciò significa che la critica stessa dovrà confrontarsi con altri linguaggi, fare ricorso, come ogni vera scienza, all'immaginazione extrascientifica oltre che agli strumenti suoi propri, e appropriarsi ancora di nuovi strumenti per affrontare contemporaneamente un terreno testuale e a-testuale, referenziale e pragmatico.
L'intoccabilità del "testo originale" è solo uno degli atteggiamenti possibili della sua ricezione ed esecuzione, e nel tempo stesso l'importanza assegnata alla ricostruzione quanto più possibile esatta dello stato di un testo in un momento dato è probabilmente un'acquisizione irreversibile della modernità. Questa convivenza di atteggiamenti, apparentemente inconcepibile, sarà probabilmente un carattere della memoria futura, che le nuove tecnologie, invece di annullare, favoriranno. Ciò avrà probabilmente anche un effetto "pluristilistico" sulla critica stessa che, di là dalle poetiche storicistiche e strutturalistiche, potrà forse configurarsi come una critica costruttiva e "conglomerativa", che si misurerà innanzitutto con la concertazione di contesti, e assomiglierà sempre più a una specie di architettura mobile, a una scienza degli accessi.
Ma tornando alle questioni dello stile e del genere, è chiaro che non si propone, allo stato attuale, un'astratta epistemologia degli stili, né una rassegna delle scuole e dei movimenti. Si vorrebbe piuttosto cercare di invertire la direzione dell'indagine, ponendo al centro quei luoghi di scambio dove hanno preso forma certi problemi letterari che sembrano ancora i nostri, individuando le configurazioni dialogiche - ovvero gli "stili", secondo quanto si è detto, in cui si riverberano le possibili soluzioni, il "come sarebbe potuto essere" delle scelte formali, grazie al quale si può tentare una storia contrastiva. E in questa prospettiva il Novecento appare un ricco laboratorio ancora acceso e produttivo, nelle risposte diverse che, a vari strati, fornisce a un medesimo insieme di problemi.
Quanto alla cosiddetta crisi delle retoriche intermedie, che significa poi il venir meno di ogni spazio discorsivo tra l'individuo e la totalità del mondo, essa sembra colpire direttamente la letteratura, che in quello spazio si collocava. E tuttavia del fenomeno si può forse dare un'interpretazione in parte diversa. La proliferazione di discorsi strutturati è sotto gli occhi di tutti. Da un lato si è assistito a un fiorire inconsulto di miti minimi, proprio attraverso quei media che si vorrebbero causa di tale azzeramento delle "retoriche intermedie". I produttori di discorsi non sono più i "corpi intermedi" alla Weber, bensì una serie di entità diffuse (comunitarie o commerciali, dagli Alcolisti anonimi alla Universal Pictures, dagli ecologisti alla Microsoft, per fare qualche esempio), o meglio gruppi o aziende che propongono o impongono pratiche comportamentali o stili di vita spesso dotati di forti implicazioni estetiche. Dunque quello spazio intermedio, in realtà, è zeppo di storie e di interpretazioni la cui unitarietà è riconducibile proprio a fattori "stilistici" più che istituzionali. Dall'altro lato, per quanto riguarda più strettamente la letteratura, si è assistito più che altro a una disseminazione del letterario, e a una crisi delle istituzioni che ne riproducevano le funzioni, a cominciare dalla scuola. Ma non è difficile ritrovare, nella selva dei discorsi intermedi, che a poco serve condannare moralisticamente in toto se costituiscono di fatto la nostra esperienza ed esistenza, molte tracce di un sapere letterario spesso dotato di profondità culturale. Viene da pensare che un costume teorico in cui l'autonomia dei linguaggi e delle singole arti era considerato prioritario debba cedere il posto a un'impostazione che non rinunci affatto a un'autonomia dei punti di vista, ma scelga l'esportazione dei propri strumenti, o addirittura l'usurpazione degli "oggetti", come pratica corrente.
Federico Pellizzi